La grandezza, finalmente
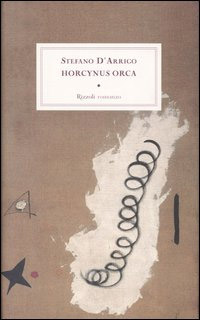
A chiamarla in causa, nell'ultimo numero della rivista Fernandel, è Antonio Moresco, che rende omaggio, fortemente e diffusamente, all'unico vero gigante del Novecento italiano, Stefano D'Arrigo.
L'intervento di Moresco è da leggere per intero ma c'è un aspetto che a me preme rilevare: Moresco, mentre legge, (eh, sì, anche lui c'è arrivato tardi, sviato, confuso e offeso - nella vista - da un'edizione economica troppo economica) ammira, si esalta e soprattutto s'indigna. S'indigna contro il mondo delle lettere. Non è che ci voglia molto a indignarsi contro il mondo delle nostre lettere. È uno sport nazionale, praticato soprattutto dai meglio introdotti in quel mondo. Io non sono facile all'indignazione, neanche per cose ben più gravi della sorte di un libro, anzi aborro i professionisti dell'indignazione. Ma ogni volta che mi sono immerso nelle profondità di Horcynus orca ho provato una sorda indignazione, che quasi non mi permetteva di andare avanti nella lettura.
Cosa mi avete consigliato per quarant'anni, recensori imbecilli e professori ottusi?
Che vi affannate a cercare capolavori oltralpe, oltreoceano e oltre la galassia, quando avete davanti al naso l'immensità? Questo non è un romanzo, è il libro. Non un libro di culto, ma il libro del culto. Che contiene materia per tre o quattro capolavori (dice Moresco, e si limita, oh, quanto si limita). Che, unico, può sostituire, se mai sarà necessario, il capolavoro di Manzoni che alcuni vorrebbero troppo vecchio per le nostre aule. C'è qualcosa di mostruoso in questa congiura del silenzio su Horcynus Orca, mi sono sempre detto. Non so chi l'ha ordita, chi contribuisce a perpetuarla, non m'intendo di logiche editoriali o accademiche. Ma come si può ignorare - o far finta di ignorare - un'opera del genere? Sta lì, immensa, da anni. L'editore non è certo tra i minori. Pubblicità, all'epoca, ne ha avuta (purtroppo, perché ci sono veri professionisti del gonfiaggio che hanno l'impudenza di denigrarla col pretesto del battage pubblicitario).
Mi sono dato molte, implausibili risposte, senza però darmi molta pena, all'inizio: il tempo, si sa, ristabilisce i giusti valori. Ma il secolo è passato, qualsiasi pischello entra direttamente nei "Classici" senza passare dal Via, e ancora non c'è uno studio su Horcynus orca. "Otto righine in tutto": Moresco lamenta la sproporzione degli spazi sulla Garzantina. E forse non sa che altrove non c'è neanche un rigo. Si scrivono libri e saggi su chiunque ma i contributi su D'Arrigo sono praticamente inesistenti. Certo, D'Arrigo ha avuto sostenitori (di viventi, in realtà, uno: Pedullà, che però non mi risulta abbia mai scritto un vero e proprio libro su di lui, come ha fatto, per esempio, con Gadda). Un volume c'è stato, d'autore non famoso ed editore disperso, forse ho ancora l'appunto oppure l'ho buttato in un momento di rassegnazione. Anche una tesi di laurea pubblicata, mi sembra.
Ammettiamo, per un istante, che ai lettori settentrionali l'ambientazione e il lessico possano risultare lontani, faticosi. Che dire di noi meridionali, in particolare di noi pugliesi, che ci arrampichiamo sugli specchi per restituire dignità e memoria a qualsiasi scrivente della nostra terra? Capaci di resuscitare e valorizzare anche gli autori più datati? Quanti leggono D'Arrigo in Puglia? Soprattutto, quanti sanno di doverlo leggere? Perché questo è il punto. Ci si può sottrarre, è comprensibile: quanti di noi, fuori dalla scuola, accettano di calarsi nell'Inferno dantesco? Così come Moresco, pur possedendo il volume di D'Arrigo e avendone subodorato l'eccellenza, si è sottratto per vent'anni all'Orca. Ma qualsiasi alfabetizzato "sa" che da Dante non si può prescindere. Nessuno legge l'Odissea ma tutti conoscono il mito, tutti sanno che la nostra civiltà è per intero lì dentro. Mentre nessuno si sente in colpa se non conosce il nome di D'Arrigo.
E intanto, a ristabilire le gerarchie, con un articolo forte, nobile e appassionato su una rivista bella ma poco diffusa, è uno scrittore settentrionale, che del silenzio ha fatto tristemente esperienza. Moresco descrive anche il suo anomalo avvicinamento all'opera.
Ancor più anomalo, forse, il mio meschino approccio da rapina: avendo letto in un intervento di Pedullà l'accenno a un brano che poteva servirmi per un articolo sulla pesca subacquea, mi sono messo in caccia. Preso in prestito il libro, che non avevo nessuna intenzione di leggere (era già condannato: discusso romanzo-fiume, opera dialettale, roba da topi di biblioteca) ho cominciato a scorrerlo: la mole non m'impressionava, sono un compulsatore da campionato. Te lo trovo io il signor Monanin. Ma il signor Monanin non era rintracciabile in scene precise. Non si trattava di individuare un'azione: egli era nelle considerazioni di un marinaio, e poi nei pensieri di un altro, fluttuava nei mari, sgusciava come un'anguilla e io dietro, scoprendo donne, uomini, fere, universi, a velocità vertiginosa, balzando avanti e indietro, attardandomi per disseppellire tesori. E quando mi riscuotevo per inseguire la mia citazione mi rendevo conto di essere stato vicino alla sincope anossica. Quando l'ho trovata, la citazione più sudata di tutti i tempi, ero ormai schiavo del libro. Schiantati, svuotati, balbettanti, così ci sentiamo noi comuni frequentatori dell'Orca dopo esserci abbandonati al libro.
Per
diverso tempo, con un'amica che aveva scoperto il libro insieme
a me, ci siamo assegnati i compiti a vicenda. Leggi questo, e tu
leggi quest'altro, ma rifletti su questo. Ricopiavamo pezzi
dell'opera e ce li passavamo, senza parole, increduli. Brandelli
che sarebbero bastati a fare, ciascuno, la fortuna di un autore, di
un poeta.
Cosa possiamo fare noi, oltre ad auspicare un'edizione
economica più curata, magari divisa in più volumi, con bordi
adeguati ai lati delle pagine, che non obblighi "a strappare una
delle pagine bianche in fondo al volume, della stessa grandezza e
colore delle altre del libro, e inserirla a ogni giro di pagina nella
scriminatura, per delimitare almeno a uno dei lati le masse di
stampa"? Non possiamo che tentare di dare un'idea delle nostre
impressioni, disorganicamente. Possiamo riportare, come fa
Moresco, disordinati appunti scritti sul sacchetto del pane.
Possiamo sostenere, insieme a lui, che "questo libro di solitudine
e di combattimento deve conquistare il posto che gli spetta in ciò
che resta della vita spirituale del nostro paese e nella nostra
lingua", dare anche noi "un piccolissimo contributo per
strapparlo all'oblio cui è stato condannato e perché nuovi uomini
e nuove donne riescano a trovare e inventare nelle loro vite e nei
loro corpi lo spazio per la sua accoglienza e la sua irradiazione,
per portarlo, sugli scudi, nel nuovo secolo e nel nuovo
millennio."