Visite guidate
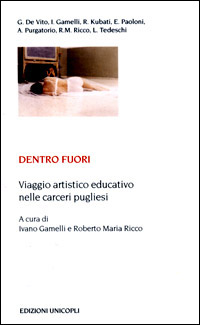
Ho partecipato a un viaggio nelle carceri pugliesi. Qui il mio contributo al libro che ne è stato tratto, DENTRO FUORI.
prologo
Sequestrati. Un piccolo sequestro di due giorni per imparare a creare gruppi tra i sequestrati. Con Ivano per guru e disparati compagni di pena sul conto dei quali fare felici scoperte: una è l'amore per il lavoro, scelto, non subito, nonostante l'ansia e lo stipendio ridicolo, di una giovane direttore C2. Per uno come me, abituato a pensare al pubblico impiego, specie in questo settore, come a un ripiego, l'idea che un laureato in legge trovi questo lavoro più interessante di quello di avvocato o di magistrato, o di una funzione in qualsiasi altra amministrazione, è sbalorditiva.
Non tutti i sequestri sono così piacevoli. Stiamo per affrontarne uno vero.
Spettacolo
Qualche tempo fa sono stato negli studi di Saxa Rubra per un intervista radiofonica. Gli Studi di Saxa Rubra. E'una formula che si sente spesso nominare, in radio, in televisione. Arrivandoci col trenino non è che faccia una bella impressione: erbacce, ponticelli precari e reticolati, un paesaggio pasoliniano. L'ingresso è costituto da un bugigattolo prefabbricato in cui si sta molto stretti e se il fax con il tuo nominativo non è arrivato rischi di aspettare parecchio davanti al gabbiotto della guardia giurata in questo ambientino malmesso, sporco, rudimentale. Quando finalmente passi, e ti trovi all'aperto tra i vari fabbricati la sensazione di sollievo non dura molto. Si vede, sì, che i fabbricati sono moderni, addirittura con qualche svolazzo architettonico, ma non riesci a sentirti a tuo agio. Bah, ti dici, gli studi sono studi, sono sempre un po' così, un barocco al contrario, con le facciate sgarupate e gli interni sfavillanti. Ma dentro la sensazione non migliora, e capisci perché i dipendenti lo chiamano Alcatraz.
Figuriamoci cos'è l'entrata in un vero carcere (istituto penitenziario, certo, certo). E invece, all'Istituto di Taranto, i posti di controllo (tre: l'ingresso vero e proprio, il cancello scorrevole dopo il parcheggio e il bancone all'interno della palazzina con amministrazione e locali degli agenti) risultano meno claustrofobici, meno inquietanti. Non si sta al chiuso e intorno c'è aria, tanta aria. Una felice eccezione? Occorre considerare che questa casa circondariale (circondariale, del circondario, beh, non è il caso di stupirsi se un funzionario ha definito i detenuti "produzione locale") è situato tra altre grandi aree recintate con ampi capannoni: un centro commerciale, l'Auchan. C'è una logica? anche quello universo concentrazionario, istituzione totalizzante, atopia. Ma non facciamo poesia.
Cerco di non lasciarmi fuorviare dalla relativa piacevolezza delle strutture (fungo futuristico centrale invece delle torrette laterali, spazi ampi, padiglioni - relativamente - luminosi, silenzio) e mi concentro sulla scorta: siamo i testimoni di una staffetta degli agenti, alcuni con tuta grigia, stivaletti, anche armi mi sembra, altri hanno una divisa, assomiglia a quelle dell'aviazione. Non vengono maneggiate moltissime chiavi nel tragitto scortato verso la sala deputata, ma mi colpisce il loro colore: sono dorate, brillano, sembrano chiavi per il paradiso, non le lugubri chiavi per le segrete.
Uno dei miei più tipici interrogativi "filosofici" adolescenziali era: cosa differenzia un prigioniero da un secondino? Ovviamente mi figuravo una prigione piuttosto all'antica, in cui davvero, da mane a sera, le due figure conducevano esattamente la stessa vita, soffocavano tra le stesse mura. Non giungevo all'estremo di figurarmi antichi manieri in cui i guardiani non lasciavano il carcere neppure di notte. Mi bastava riflettere su chi, a sera, tornava a casa, altra tetra prigione. Sull'insufficienza del salto esistenziale costituito dalla maggiore confortevolezza di quest'altro alloggio e da una maggiore gustosità della cena. Ovviamente la location contemplava gli inverni di un paese nordico, durante i quali un'"ora d'aria" serale per la guardia era inconcepibile. Quando, nella più rosea delle raffigurazioni, la guardia era sposata, potevo ravvedere l'unica grande differenza: la donna, il sesso. Tutto qui. In fondo non c'è altro: il sesso è motore di tutto. E, forse ancor oggi, questa è l'unico vero grande castigo della pena detentiva: l'assenza del sesso. Di quello considerato normale, almeno.
Il confronto, oggi, non è proponibile: le quaranta, anzi le trentotto, anzi le trentasei ore settimanali, scavano un abisso tra le due figure. Anche se i detenuti continuano a sfottere gli agenti con la solita battuta: "Io tra un mese esco, e tu, quando esci?" Ma con l'ambientazione precedente c'era di che pascere le considerazioni pessimiste della mia gioventù: ogni esistenza è un'esistenza prigioniera, siamo tutti carcerati, il lavoro è oppressione.
In sala gli attori riscaldano la voce con un coretto dello spettacolo e poi si nascondono dietro all'enorme panca-palcoscenico. Attendiamo l'ingresso degli ospiti, e già mi creo un problema di definizione.
Un argomento di alcuni avversari della pena di morte è: lo Stato non può arrogarsi il diritto di commettere un atto che se commesso da un individuo verrebbe chiamato omicidio. Omicidio. Questa parola continua a risuonare alle orecchie degli sprovveduti, turbandoli fortemente. Ma chiunque abbia un minimo di pratica dell'esercizio retorico sgama subito il trucco: sarebbe come dire che ogni volta che becco una multa per divieto di sosta, la comunità si arroga il diritto di compiere un atto che, compiuto da un privato, verrebbe definito estorsione. E, parimenti, quando mi commina una pena detentiva, lo Stato commetterebbe quello che, compiuto da barbaricini, viene chiamato sequestro.
Dal punto di vista del diritto, e anche dell'etica del diritto, la differenza c'è e come. La multa non è un'estorsione e la detenzione non è un sequestro. Ma è molto utile usare certe parole: ti impongono all'istante un altro punto di vista: non necessariamente più adeguato, ma, per la ricchezza dell'approccio emotivo, utile alla completezza del quadro.
Bisognerebbe provare a chiamarli così, sequestrati. Non detenuti, eufemismo per indicare i carcerati, delicatezza che ci conforta nel politically correct ma non sposta di un millimetro la nostra percezione. Sequestrati. Perché il loro sentimento non può differire di molto da quello delle vittime delle organizzazioni criminali (il fatto che in carcere non dovrebbero esserci innocenti non cambia in nessun modo, io credo, la percezione che il corpo ha della gabbia). Oppure ospiti, che non si sbaglia: sono ospiti delle strutture ma fanno anche da ospiti a noi, estranei sperduti.
Arrivano a piccoli gruppi e seguono compunti le indicazioni degli agenti: dalla terza fila in poi. Riempiono il settore di destra e poi, gradatamente, quello di sinistra. La seconda fila di sinistra è riservata ai cinque eletti, quelli con cui si lavorerà. La gabbia in cui siamo è doppia. Non mi riferisco al fatto che la grande gabbia sia suddivisa in ulteriori gabbie e che in ognuna siano altre gabbiette ma alla condizione degli attori, prigionieri di una scatola all'interno della Grande Gabbia (o gabbio, che dir si voglia). La scatola è la scena, anche quando non segnata da quinte e palcoscenici, anche se esplosa e dispersa. Gli attori, anche di strada, anche nascosti tra il pubblico, sono sempre all'interno della gabbia delle relazioni, della finzione, della costruzione - o decostruzione - scenica. Il teatro viene al terzo posto, nelle preferenze dei detenuti, tra le attività carcerarie. Dopo il lavoro e il calcio, spiegava Mattia Feltri in un servizio sul carcere di Pisa. Il Miles (Mails, leggerà qualcuno, pensando a musicisti afroamericani). Plauto attualizzato (mitragliette invece dei gladi). Localizzato, soprattutto, con le ingiurie regionali. Ma c'è poco da attualizzare, dice il regista, le differenze sono pochissime: non siamo mai usciti dal cupo mondo dell'antica Roma. Diverse le commedie ateniesi, che hanno un orizzonte. Plauto è già calato nelle nostre immodificabili città vecchie, o nei quartieri troppo nuovi. Un finale ancor più amaro, forse. Nessuna distanza, quindi, per il pubblico, specie per questo pubblico.
E io? Spettatore. Spettatore non comune: il vero pubblico consiste nei detenuti. Io sono in un'altra condizione: fisicamente tra loro ma emotivamente dieci metri più su, come un nobile che dal palco si diverte più a osservare la fauna della platea che lo spettacolo propriamente detto. Io so cosa rappresenta lo spettacolo. So quali proiezioni, quali identificazioni, può suscitare nel pubblico a cui è destinato. E sono più interessato alle reazioni dei detenuti che al resto.
E invece, sequestrato dallo spettacolo, quasi dimentico i sequestrati. Non del tutto: come non sentire, sia pure dalla prima fila (mi ero seduto in un fila intermedia, da sequestrato, ma, benché la fila fosse vuota, sono stato invitato a sedermi nella fila delle "autorità") il divertimento, anzi l'entusiasmo degli spettatori? Si divertono quanto me, ne ho certezza percependo un "chilemmuerti", il nostro più sincero e affettuoso segno di apprezzamento.
Non so se è merito di Plauto o del regista. Buona parte del merito va sicuramente degli attori, splendide marionette. Non sai se apprezzare di più i ghigni e le mossette del "sopra la panca" o le fissità tragiche del "sotto la panca" in cui le marionette si disanimano. Lo spettacolo vale di per sé ma, per il lavoro che andiamo a tentare, è fondamentale l'insistenza sulla finzione, sui travestimenti e sulle maschere. Così come la riflessione che può partire dalla frase finale del maramaldo dopo che è stato costretto a chiedere perdono alle persone "perbene": e chi sarebbero le persone perbene?
Per diversi minuti gli astanti, dal posto, si complimentano con gli attori. "Non è facile far ridere, qua dentro, e voi ci siete riusciti in pieno". Qualcuno - è uno dei "nostri" - non si capacita che non siano apparsi in televisione: "Non è possibile, voi siete davvero bravi, com'è che non state in televisione?" Bella domanda, Ciccio. Intanto gli attori depongono le maschere. Seduti al tavolo-panca-palcoscenico, chiacchierano con gli astanti e contemporaneamente si struccano.
Infine i detenuti escono. Alcuni aiutano i tecnici a portar via gli impianti. Constato - ma me ne ero già reso conto all'inizio e poi durante i pochi momenti di distrazione dallo spettacolo - che esiste un'incredibile intesa tra guardie e sequestrati. Gli agenti controllano ogni dettaglio in continuazione e usano pochissime parole: i richiami sono gesti appena accennati, anche soltanto sguardi. Capisco di colpo perché il carcere, in gergo, viene definito "collegio": certi dettami sul comportamento hanno poco a che vedere con la sicurezza, si tratta di compostezza, di decoro, di "educazione". Si tratta di "controllo", di "dipendenza". Si tratta di cose così sottili che probabilmente sto dicendo un sacco di fesserie. Ma questo percepisco. Anche se potrei agli agenti come pastori che conducono, contano, riaccompagnano le pecorelle.
Ci tratteniamo a fare conoscenza dei cinque ospiti con i quali dovremmo lavorare. Sono interessati e divertiti ma non riusciamo a capire molto di loro, non solo perché abbiamo poco tempo ma perché molte parole si perdono nel frastuono che i tecnici fanno nello smontaggio. Roberto, il coordinatore dell'ambaradan, inizia subito i giochetti sull'identità, anzi sulla carta d'identità.
Chiede ai nostri amici, ma anche a me e Francesca, come abbiamo percepito i vari personaggi. Siccome gli attori, ormai rivestiti, si soffermano tra noi, Massimo, che dei cinque è il più preoccupato delle convenzioni, pospone sempre agli apprezzamenti negativi un "intesi come personaggi, s'intende". Roberto chiede - si chiede - soprattutto chi meriti fiducia, quanta e perché. Il servitore del miles, il guardiano della bella, viene percepito come infame, perché racconta al padrone le trame degli amanti. Pare che a nessuno venga in mente che lui può venir considerato un fido, un vero fedelissimo, perché è al padrone che deve fedeltà e non ai momentanei compagni di viaggio. La concezione della fedeltà è strettamente legata alla percezione dell'identità dei malavitosi ma non abbiamo tempo di scavare in questa direzione. Roberto annuncia che lui non tornerà più. Saranno altri a continuare. Prima evasione.
Prima giornata
Con Lello e Francesca attendo nel grande stanzone l'arrivo del gruppo. Due agenti fanno considerazioni sulle condizioni carcerarie. L'atteggiamento di uno è negativo non solo sulla rieducazione ma addirittura sulla detenzione: soldi spesi inutilmente, la testa bisogna tagliargli. Non si capisce bene da quale reato in su, sembra che decapiterebbe anche per divieto di sosta. L'altro, più possibilista (ma nessuno, tra quelli che ascolto, crede davvero al reinserimento: li vedono sempre tornare) sembra quasi invidioso (l'erba del detenuto...), sostiene che cure e TAC vengono concesse prima a loro che a lunghe file di cittadini. E che dire del dentista gratis, che le persone oneste se lo sognano? I titoli di studio, poi, te li buttano dietro.
So che c'è il liceo artistico ma il titolo per cui si studia di più, qui, è la licenza elementare, sembra incredibile ma decine di persone non frequentano oltre la prima, e poi ci sono gli stranieri.
Due facce nuove. Uno pensa al carcere come qualcosa di lento, di poco mutevole, di stabile, e invece due nostri amici sono stati trasferiti, almeno credo, e ne abbiamo di nuovi. Uno di loro è deluso dalla mancanza della nostra "collega" fotografa: avendo firmato una liberatoria, non avendo altre informazioni sul progetto (sono molto laconici, gli agenti e gli educatori) ed essendo pure belloccio, pensava si trattasse di un set. E' anche un po' scettico sull'utilità delle scritture.
I nostri amici sono tutti "permessanti", tranne uno, che ha da scontare altri anni per arrivare in zona permessi. Il giudice di sorveglianza, qui, li concede con una certa larghezza (a fronte di una buona condotta, concede il massimo dei giorni consentiti dalla legge) ed è uno dei motivi per cui Taranto è un carcere ambito.
Su un settimanale avevo trovato un'apprezzabile inchiesta sulla situazione delle carceri italiane. Notizie circostanziate sulla quantità di celle singole, sulla dislocazione dei servizi igienici, sui turni sanitari, sulle attività praticabili. Ma il tutto viene riassunto in uno specchietto agghiacciante: del tutto simile a cento altri specchietti dello stesso e di altri periodici, contempla tra i criteri di valutazione il "tempo libero" e riporta, di fianco al nome di ogni carcere, le stellette. Come di un albergo, appunto, come di una località di villeggiatura che uno si sceglie. Anche qui molte possibilità di giocare sul doppio senso, sulle frasi gergali. E, d'altro canto, il sospetto che non sia soltanto scherzo: in maniera più o meno legittima, qualche scelta probabilmente viene fatta. Ci sono carceri, si sa, che i boss cercano di evitare. E nelle quali, magari, si viene mandati "per punizione".
Dal raffronto di queste carceri si evince una schizofrenia di fondo: dove c'hai il cesso accanto alla branda (e magari in cella ce ne sono altre quattro di brande) trovi ottime possibilità di rieducazione, studio e socializzazione. Dove stai largo e comodo con la doccia calda in camera (in cella, certo) non puoi quasi parlare con nessuno. Aborrite ovunque le finestre a bocca di lupo: micidiali per il caldo e l'impossibilità di guardare fuori (non solo per percepirlo, il fuori, e svagarsi ma anche per riposare gli occhi sull'orizzonte, focalizzazione necessaria alla salute).
Ma le classifiche più attendibili le stilano i carcerati stessi: "il migliore dei normali è Favignana, il peggiore Sassari, il peggiore degli speciali era l'Asinara, il migliore Voghera (perché? era un carcere "casalingo"?). Lo dice, nell'intervista al settimanale, Antonino Marano, un professionista: quaranta anni di carcere (ma dopo quarant'anni non dovrebbero mandarlo in pensione? Forse ai sequestrati si applicano i privilegi di Primari Ospedalieri e Professori universitari, autorizzati a restare sul campo oltre l'età pensionabile).
Altra scoperta: il carcere, qualsiasi carcere, è la meta più ambita dei minori. Nulla può farli più felici che andarsene dal minorile. Qui, mi dice Vincenzo, nessuno ti rompe le scatole. Fai quello che vuoi. Lì c'erano mille regole, orari per ogni cosa, fai questo, fai quello, ti stavano sempre dietro. Gli adulti possono poltrire, questa sembra essere la morale del caso.
A questo punto devo constatare un'incredibile concordanza d'opinioni tra l'agente che è rimasto a sorvegliare (da considerare: l'agente, abbastanza giovane, è molto amichevole con i detenuti, ci scambia battute, a uno mette la mano sulla spalla; non è, insomma, uno che auspica la durezza per pregiudizio o attitudini caratteriali) e Massimo, che è stato a Poggioreale (oppressivo per tutta la giornata, a cominciare dalle sei di mattina quando devi stare in piedi davanti alla branda quasi sull'attenti e guai a un torso nudo), un inferno con la sola splendida oasi del campo di calcio in erba. Lì davvero, sostiene Massimo - esattamente come l'agente - uno si scorda la delinquenza (anzi lo "sfamare la famiglia", perché sembra indelicato pensare che possa esserci un diverso movente per delinquere). Non sarebbero dunque l'umanità e la comprensione a rieducare ma la deterrenza del carcere duro! I detenuti lo pensano.
Lavoriamo sulle scritture. Poche righe a partire da una piccola frase. Un pretesto per la riflessione, il colloquio, la drammatizzazione. Ma realizzi che, davvero, la scrittura è un'altra cosa. Che questo foglio bianco, col suo sforzo solitario, è una scavatrice, una macchina movimento terra. Anche se l'esito è banale, in quella massa di terra smossa c'è sempre qualche parola o qualche concetto rivelatore.
Per quanto possano essere diversi gli scopi, c'è una grande affinità tra quello che facciamo e i corsi di scrittura creativa: il focalizzare l'attenzione, l'asciuttezza, l'enucleazione del dettaglio rivelatore, l'indirizzare verso l'oggetto, il rifiuto della parola astratta. Tecniche che, mi avvedo ora, sono in fondo quelle della scuola elementare, troppo presto abbandonate.
"L'unica cosa in cui in carcere si diventa buoni: a scrivere". Parole di Giancarlo De Cataldo, magistrato e romanziere, a proposito del libro di Nazzareno Zambotti (Perché non sono diventato un serial killer, Einaudi). Zambotti, una vita in galera, è definito un cane sciolto rispetto alla criminalità organizzata. Beh, anche gli scrittori dovrebbero esserlo, rispetto alla Società organizzata, perciò Zambotti è a posto con i requisiti.
Nell'indagine sui luoghi "di sosta", si parla molto della finestra, com'è ovvio. Prima considerazione: il mondo si divide in due categorie, i fortunati (camera con vista su strada, Auchan e appartamenti) e gli altri. Seconda considerazione: se nelle altre celle, quelle con vista sulla campagna, c'è un appassionato di motocross, può ritenersi fortunato anche lui. Terza considerazione: una finestra non è uguale a un'altra, anche se con vista uguale. Massimino, infatti, si sente a casa se guarda dalla sua finestra ma non se guarda da quella della cella accanto. Quarta considerazione: uno davvero giù (Massimo) non la può neanche vedere la finestra. E' pura angoscia riscoprire che il mondo vero esiste (mi fa male la testa). Quinta considerazione: c'è chi di finestra è malato. Vincenzo non farebbe altro: i bambini che giocano, i giovani che si mettono d'accordo su dove andare, le macchine che vanno e vengono dall'Auchan, le mamme, i balconi. Massimino ha una strana, bella immagine per i bambini che giocano al calcio su due campi lontani: "sono piccoli, sembrano buste che volano, ma le loro grida si sentono forti ed entusiasmanti".
Per Massimino il luogo d'elezione è solo apparentemente la finestra. Ci sta davanti, sì, ma per fumare la sigaretta, ascoltare musica dal walkman e viaggiare con la fantasia. Più che progetti, infatti, mi sembra che accarezzi sogni. Fa il liceo, credo, no, lavora soltanto, forse, nelle manutenzioni, ma più che prefigurarsi un lavoro normale fantastica sull'essere un grande attore o cantante (molto improbabile) o un grande atleta (decisamente impossibile). Infatti scrive: "quello che avrei voluto fare nella vita", non "quello che vorrei fare". Probabilmente l'unico modo di sopportare la pressione, qui, è la pura fantasticheria, ma mi chiedo se non faccia parte di una psicologia che porta poi ai margini (se non posso avere quel grande destino, me ne faccio uno comodo e lussuoso senza faticare, magari con lo spaccio).
Per Fernando l'unica vera finestra è la scuola. Il foro nel muro è un'illusione, una sciocca evasione: l'unica vero contatto col mondo te lo dà un professore, o uno come noi, perché rappresenta un contatto reale, e ti fornisce strumenti, cose che possono davvero essere utili. La finestra, le chiacchiere coi colleghi, tutte cazzate.
Per Massimo e Michele il luogo d'elezione è la Cappella, ma solo per Michele sembra fondamentale la religione, o, comunque, l'insieme del rito, del prete, dei volontari che spesso lo accompagnano: nella descrizione si sofferma sulla croce di Gesù, sul pianoforte, sulle immaginette. Massimo neanche la nomina la messa, per lui conta solo la figura della suora. Non parla che di lei, di quello che gli ispira: anche quando il "compito" riguarda la secca descrizione di luoghi e persone, lui si concentra sui sentimenti che la suora gli ispira. Sente, e non sbaglia probabilmente, che lei è l'unica che sta lì veramente per aiutarli. Vede che soffre per loro, che è felice quando interviene sulla Bibbia e questo lo riempie di gioia. Vede nel suo volto l'immagine della Madonna, poi la definisce "una mamma" e per uno che i quaranta li ha superati mi sembra che sulla faccenda "madre" ci sia da scavare. Ma io non faccio lo psicologo.
Pensierino del giorno (anticipato nel precedente incontro): "Cos'è la prigionia" (qual è l'oggetto, situazione, persona, colore, odore che vi ha dato, al primo ingresso nel carcere, la sensazione precisa della reclusione?).
Angelo ha realizzato davanti al cancello scorrevole esterno, Massimo collega la prigionia al rumore delle chiavi, Fernando alla presenza dell'agente. Vincenzo ha percepito la sua condizione al risveglio (la vista delle sbarre). Tutti concordano sulla conta e soprattutto sulla battitura dei ferri, che dovrebbe controllarne la saldezza (secondo qualcuno, spesso è solo tortura psicologica).
Seconda giornata
Due di meno, Angelo e Vincenzo. Noia e sonno, forse (la primavera è iniziata) o poca passione (quisti volunu ssannu tutti li fatti nuestri). I nostri amici sono abbronzatissimi. Escludendo che si facciano le lampade e considerato che le ore d'aria non sono poi tante, non si può che pensare che bevano il sole, forse anche alla finestra, come noi e gli agenti non ci sogniamo nemmeno. Gli agenti, dal colore, sembrano loro i sepolti vivi. Eppure vivono in quella città a proposito della quale Gadda parlava di "gioia della chiarità marina".
Domanda del giorno (giorno molto corto, chè per disguidi vari abbiamo cominciato tardissimo): cosa rende, più d'ogni altra cosa, l'idea della libertà, del "fuori"?
Le risposte sono molte e quasi tutte ovvie, tranne una: il traffico, che per noi rappresenta la pena peggiore. "Mare" e "boschi" sembrano simili a "stadio" eppure, prescindendo dagli spazi, sono l'opposto: folla contro solitudine. Ma entrambe, insieme all'andarsene in giro con gli amici, si oppongono allo "stare in casa", che in fondo è un altro luogo chiuso, una gabbia, anche se più che lo "stare" conta la cucina della mamma. Fernando non condivide la situazione scelta da Massimo (passeggiare con la figlioletta): è bellissimo, l'affetto paterno è un grande sentimento, ma sono gli amici a renderti libero, il bar. E il peso delle stoviglie (qui ci si abitua a bicchieri di carta e posate di plastica: leggerezza, inconsistenza). E' importante anche (ma questo è un suggerimento di Mimmo, l'agente) che la birra tu possa berla dalla bottiglia e non dalla lattina, unico contenitore ammesso nel carcere. Mi accorgo che tra le molte situazioni manca quella fondamentale. Massimo ci si è avvicinato di più con un "dialogo con la compagna".
Si chiama così, adesso? Gli ospiti si sciolgono e, beh, sì, certamente, lo aggiungono al resto, forse li tratteneva la presenza di Francesca o pensavano che noi volessimo accademia, poesia, arcadia. O non volevano che li stigmatizzassimo come allupati. Oppure, molto semplicemente, l'attività che fa girare il mondo non corrisponde esattamente alla libertà: si fa al chiuso, del resto, e costituisce un legame. Il Buddha direbbe che è una catena.
Mentre il gruppo scrive sgranchisco le gambe lungo la palestra. Mimmo, l'agente mi raggiunge, con tragitto speculare e mi racconta della sua esperienza teatrale, legata al suo gruppo di sbandieratori. Chiarisco che io col teatro non ho nulla a che fare e quando sente che scrivo anche sui giornali, mi chiede di cosa, vuol sapere la mia opinione sulla guerra: è l'unico del suo paese ad aver esposto la bandiera americana. Approvo l'atto anticonformista ma la sua non è solo lealtà atlantica: c'è un'avversione per l'Islam, dovuta all'esperienza nelle carceri di Bolzano. Il comportamento dei molti detenuti arabi lo ha scioccato: gente che si accoltella per niente in continuazione, che cammina con le viscere in mano, ingoia lamette, litiga e crea danni e confusione per nulla, quasi per istinto. Razza bastarda, insomma. Beh, dico, lì dentro vedi i peggiori, ovviamente. A proposito, com'è che si concentrano al nord? Perché qui non possono impiantare granché: la piazza è occupata. Su, trovano campo libero.
Taranto, poi, è un altro mondo: sono successi fatti gravissimi in passato, tra cui l'esecuzione di un'agente, uno scelto a caso per colpire il corpo e c'è stata per reazione una grande durezza, i detenuti dovevano camminare rasente il muro a testa bassa, con le mani dietro la schiena. E' passata, infine, adesso si scherza anche, ma non è semplice dimenticare un collega giustiziato: si comprende anche un certo scetticismo nei confronti di noi "civili", che si va lì a cazzeggiare. Adesso è il tempo della carota: con il regime dei permessi applicato alla lettera i detenuti sono correttissimi. Chiedo se pensano al carcere quando sono in permesso. Quando esco, dice Fernando, basta che arrivo qui all'Auchan e mi sembra di non esserci mai stato, in carcere. Ma la prima volta non è stato così: quando ho messo piede nella macchina dopo tre anni... sentivo sempre la differenza, non pensavo ad altro. Mi chiedo se va all'Auchan perché è il posto adatto per comprare qualcosa appena usciti o se ci andrebbe lo stesso solo per immergersi in una folla "normale", e quanto conti il "prendere possesso" di una cosa che si è guardata più d'ogni altra e che più cospicuamente ha rappresentato per mesi il "fuori". Proponiamo delle scritture su cosa si immagina che gli altri facciano una volta a casa, per confrontarlo con quello che veramente ciascuno fa - o dice di fare. Non risultano grosse discordanze tra le due versioni. Massimino quando entra in casa distingue, uno per uno, il "profumo" dei suoi parenti. Dalla traccia "Quando mi guarda pensa che" viene fuori un gioco sordo ma intenso sorvegliato/sorvegliante, sui messaggi di odio e di paura affidati agli sguardi:
Quando mi guarda pensa che sono un avversario facile, e il suo sguardo trasmette paura e padronanza nei miei confronti. Il suo sguardo è uno sguardo di superiorità, io nel suo sguardo vedo che ha tanti problemi con chi gli sta molto vicino. E' convinto della sua superiorità perché è molto avvantaggiato nei miei confronti: gioca in casa e ha la penna facile. Lui pensa di avere campo facile, ma non sa che quando ho un avversario così sicuro e deciso mi piace giocarla fino in fondo, anche se gioca in casa, non ho paura del suo pubblico, ho la capacità di affrontarlo con rispetto e educazione, e di controbattere il suo gioco maschio e manesco. Con il suo sguardo può trasmettere paura, io posso trasmettere odio. Con il suo sguardo è convinto di farmi soffrire, io penso che il giudice mi ha privato della libertà ma non della sofferenza [sic]. Massimo
L'atteggiamento è quello di un western di Leone: mi piacciono quelli grandi e grossi perché quando cadono fanno più rumore.
Un altro scritto mi sembra emblematico:
Quando mi guarda pensa: chissà cosa ha fatto per trovarsi in questo luogo. Questa è la domanda che mi pongo e che credo si ponga anche la gente che incontro in questo luogo ma che viene dall'esterno. Ne incontro molta frequentando vari corsi. In particolare mi incuriosisce Valentina, quando mi fissa seduta di fronte a me e dopo un po' mi domanda: come va oggi? Tutto bene? Ed io con un mezzo sorriso le rispondo di sì. Dopo ognuno torna nella propria espressione, ma ogni tanto i nostri sguardi si incrociano, e da questo capisco che sta pensando a me. Sono sicuro che pensa: come mai si trova qua? Cosa avrà mai fatto di così brutto? Chissà se è pericoloso o se posso fidarmi di lui. E ancora: parlando non sembra cattivo, ma è questa la sua indole oppure finge? Ma no, sono sicura che è una brava persona che ha commesso qualche errore ma è recuperabile. Facendomi questo resoconto finale mi sento meglio. Io, invece, la fisso o la guardo anche quando lei non mi guarda, e penso: cosa farà mai quando non è qui? Perché vengono a fare il loro lavoro in un posto come questo? Lo farà perché vuole farlo o perché non c'è di meglio? E' veramente così o si adatta alla situazione? E tanti altri pensieri, ma non basterebbe un foglio per descriverli tutti.
Fernando
Terza giornata
Disguidi e ritardi sono cosa normale, non darebbero neppure tanto fastidio se non fosse così palese che qui ci sopportano, non amano queste attività e non ritengono necessarie neppure scuse formali, sorrisi di circostanza. Come lamentarsi, del resto, in prossimità di chi sopporta ogni giorno queste attese, l'Attesa?
Ritorna Vincenzo, il calciatore, ma non Angelo. Oggi foto, anche se quasi nessuno ha la barba fatta. Francesca che ha panni neri si mette in piedi dietro ai detenuti seduti per fare da sfondo. Massimo e Massimino dovrebbero abbandonare perché hanno giardinaggio (li pagano pure) ma Massimino è più interessato ai nostri giochi, che oggi giocano sull'appartenenza: a chi pensiamo quando diciamo noi? Anche agli amici "di fuori", ovviamente. Quelli Massimino li pensa poco e se lo fa è per vederseli davanti come in un film per scartarli a uno a uno, fotogramma per fotogramma. Fernando, invece, che è più grande e una vita l'ha avuta, pensa sempre a loro con piacere e la prima cosa che fa è cercarli quando esce.
Noi, puntini puntini. Finiamo per fare una lunga lista, forse sarebbe stato meglio approfondire un plurale per ognuno. Scontato il tema dell'amicizia, molto sentita anche se contraddetta da un pensiero più realistico:
Siamo in parte amici. Possiamo bruciare il tempo della giornata giocando a pallone, con un po' di corsa e parlando di qualsiasi argomento. Si potrebbe dire che ci aiutiamo a tener su il morale stando assieme durante il passeggio.
Una traccia è sulla falsariga del "Cosa non siamo, cosa non vogliamo". Qualcuno si lancia in una difesa non richiesta:
Non siamo invidiosi, raggiratori, avari, ingordi, indifferenti verso gli altri, lagnosi, discriminatori, doppiogiochisti, iettatori.
Chi li accusa di tali delitti? E soprattutto chi li accusa di essere iettatori?
"Non siamo delinquenti, come pensa la gente".
E' il rifiuto di un marchio esistenziale, non una protesta d'innocenza: nessuno di loro si è mai dichiarato estraneo alle imputazioni. Caso raro, pare: è un ritornello carcerario così scontato, così prevedibile e ricorrente, che appena parte, un sorrisino affiora sulle labbra di visitatori, giornalisti, compagni di pena. Io sono innocente. Ma va!?
C'è poco da ridere: statisticamente è vero nel 50% dei casi. Uno su due, è la verità. Molti anni fa Alberto Sordi interpretò un film apparentemente comico, Detenuto in attesa di giudizio. In realtà il carattere grottesco del film non derivava da forzature di sceneggiatura ma dal realistico rispecchiamento della macchina penale italiana. Quel film sembrò dar voce a un'indignazione generale: è inaccettabile che un paese civile possa concepire la carcerazione senza giudizio. Infatti, poco dopo fu varata una legge che avrebbe dovuto impedire questo sequestro "preventivo". Essendo però l'Italia quel paese in cui, abolito un ministero a furor di referendum, lo si lascia tal quale cambiando l'insegna, la carcerazione preventiva - pardon, custodia cautelare - apparentemente riservata a casi estremi, a rarissime eccezioni, è talmente usata che metà dei detenuti viene poi assolta. I condannati invocano, ovviamente, l'errore giudiziario (e anche qui c'è poco da sorridere). Qualche recidivo tra quelli incontrati (di quelli che proprio non possono dirsi angioletti) ha coniato un "quasi gol" di genere carcerario: sono innocente all'80%. Chavravvolutodì?
Sono convinto che prima di permettere a un giudice di iniziare la sua carriera, dopo il concorso, debba essere previsto uno stage di due settimane in carcere. Non dalla parte giusta, tra i funzionari che lo dirigono, ma dalla parte sbagliata, in cella. Con gli altri. In incognito. Detenuti a tutti gli effetti. Forse qualcuno potrebbe decidere di lasciar perdere. Chi se la sentisse di resistere, al carcere e nella carriera, sarebbe sicuramente molto più scrupoloso, non tanto nel comminare le pene, quanto nel decidere la reale necessità del ricorso a quella carcerazione preventiva (comunque la si chiami eufemisticamente oggi) che trova mille pretesti per essere applicata. Lo stesso dovrebbe valere per i direttori delle carceri. Come Robert Redford in quel film, Brubaker. Ma non per scoprire chissà quali irregolarità, come il direttore di celluloide: semplicemente per sentirsi addosso le norme più legittime, quelle apparentemente "civili".
Quel "non siamo delinquenti", dunque, vuol dire che non ci si ritiene delinquenti abituali? Forse un paio di loro non lo sono, scontano un singolo atto fuori dalle regole, ma un background di comportamenti al limite e un atteggiamento aggressivo non mancano. Allora, forse, si intende che la pena li ha già riscattati. Oppure che delinquenti siamo tutti, o possiamo esserlo, quindi non è il caso di stare a fidarci delle distinzioni.
Finiamo per parlare, specie a proposito di "noi della cella"(il vero gruppo, la vera sensazione di appartenenza) delle condizioni di vita, della routine.
Mi sono spesso immaginato in carcere. Nulla di strano, noi scrittori ci immaginiamo in tante situazioni. Non ero quasi mai un semplice detenuto: ero nella cella della morte. Colpa di Camus, del suo Straniero, ma anche di Koestler, di tanti altri. L'idea che, cortesemente, con il prete appresso, distinti signori bussano alla tua porta per dirti che devi crepare nel giro di tre quarti d'ora e che se ne occuperanno loro. Ma ho spesso immaginato anche la "semplice" prigionia, specie quando ho capito che in Italia qualsiasi galantuomo può essere "preventivamente" sbattuto in cella.
Immaginavo, ingenuamente, che la prigionia (superate le crisi claustrofobiche di un selvatico come me, che si sente in gabbia non solo dopo permanenze di qualche giorno in casa sua o in un ufficio ma anche nella più grande delle città, per quanti parchi e gigantesche piazze essa contenga, o addirittura in una campagna troppo abitata e perfino in mezzo al mare, se dalla spiaggia giunge qualche suono) poteva, tutto sommato, considerarsi un modo per soddisfare al meglio certe esigenze: leggere tutti quei libri "doverosi" che non si è trovato il tempo di leggere, scrivere i venti romanzi degni di Balzac che ci eravamo imposti, e poi meditare (meditare in senso proprio, con quello che le discipline yoga comportano). Quasi una pacchia, alla fin fine, ammesso che fossi riuscito a fare quel minimo di moto a me indispensabile senza sbattere (o incominciare volontariamente a dare di testa) contro il muro.
Questa falsa immagine è da attribuire a tanti romanzi e film su prigioni sonnacchiose: dai Piombi a Pellico, dalle turche fughe di mezzanotte alle carceri messicane di Salvatores, tutto un martellare sull'abbandono, la dimenticanza, il silenzio, la desensorializzazione.
Poi, pian piano, la verità. Attraverso Sofri, ma anche Cusani, scopro che il carcere è un porto di mare, un bailamme, il luogo del frastuono perenne e, soprattutto, degli orari capotici e ineludibili. Tipo la "battitura dei ferri" (anche tredici volte per notte!). Il vero problema del carcere, specie per individui "meditabondi", è la rottura sistematica delle balle. Il carcere è tutto fuorché il luogo della dimenticanza: l'Amministrazione si ricorda di te continuamente. E i compagni, se anche non si ricordano di te, hanno mille modi di ricordare a te sé stessi.
Da tutte le esperienze salta fuori una considerazione univoca: il regolamento carcerario è oppressivo. E quando vedi all'opera questa macchina tritatutto ti rendi conto che la privazione della libertà comunemente percepita, il non poter uscire da quel recinto - reticolati, mura o fasci laser che siano - la condizione, insomma, in cui dovrebbe consistere tutta la condanna, è solo una delle restrizioni, quasi la più tollerabile, la meno pesante. Le cose che non puoi fare sono così tante che quell'obbligo di residenza non pare più neanche una pena.
Qui, per esempio, in un carcere considerato a cinque stelle, all'una di notte i televisori vengono spenti (ma come sarà finito quel film?). E non vengono forniti i telecomandi, prescrizioni di cui non si riesce a capire il motivo (interferiscono con i televisori della cella accanto, dicono. Vedi che potenza: manco i telecomandi dei sistemi Bose!). L'interruttore della televisione è il "mezzo di punizione" più comunemente usato: se c'è troppo chiasso o qualcuno dà fastidio in qualche modo, si spegne la televisione a tutto il braccio. E per alcuni, qui, la televisione è tutto.
Ad ascoltare le spiegazioni dei funzionari, tutte le norme acquistano un senso, appaiono giustificate, quasi logiche. Ogni minima restrizione, ogni contorto percorso, ogni invasione della privacy, tutto trova giustificazione nella sicurezza. E non v'è dubbio che in un ambientino del genere le responsabilità siano pesanti. Però portano a precauzioni che viste da fuori hanno del paranoico. Così, se i sospetti sull'accesso di chiunque sia capitato nei casellari sembrano normali (anche se non lo sembrano al malcapitato che si illudeva su una cancellazione d'ufficio) stupisce che ci siano impedimenti per chi con la magistratura ha collaborato, magari come interprete. Un pacifico interprete potrebbe essere bersaglio di ostilità, "è per la sua stessa sicurezza", bisogna capire. Certo, poi uno capisce anche che parlare una lingua sconosciuta agli agenti è sospetto di per sé. Beninteso "è sempre per la sua incolumità: potrebbero pretendere il recapito di messaggi". Già, e soprattutto, chi ci dice che non collabori più che volenterosamente?
Chissà, forse i più sospettosi siamo proprio noi estranei: all'oscuro di quel mondo, rischiamo di scambiare per ostruzionismo un semplice disguido burocratico, per dispetto un'attesa apparentemente inesplicabile, per accanimento cinque motivate intrusioni nei laboratori.
Quarta giornata
Possibile che li abbiano infilati tutti in questo turno gli agenti veloci e flessibili? Oggi ho passato le tre forche molto velocemente: nome al volo, levata di documento e via. Al terzo check point proposta indecente: conosce la strada? E così me ne vado solo per il cortile, busso al cancello del complesso, dico Kismet e mi faccio il lungo corridoio fino alla sala, guardandomi indietro ogni tanto con un po' di preoccupazione: sarà mica come nei film, che dicono ai prigionieri di andare e poi gli sparano alle spalle? Anche l'agente in sala è discretissimo e se ne sta all'ingresso. I miei compagni hanno già cominciato con le foto, anche ai tatuaggi. Ora legale, niente nuvole, quindi Agnese è contenta della luce.
Tema: quel che in carcere non manca mai. Ma la domanda davvero interessante, quella inquietante, sarebbe stata "Cosa ti mancherà del carcere?". Perché anche del carcere si può rimpiangere qualcosa. Non mi riferisco solo agli aneddoti dei troppo anziani o incapaci che delinquono per ritornare sotto un tetto, in compagnia. Anche dei giovani intraprendenti possono finire per rimpiangerne qualche aspetto (cameratismo, strutturazione del tempo, autocommiserazione). Nella vita "normale", del resto, molti anziani finiscono col raccontare di continuo, con aria trasognata e partecipe, le loro vicissitudini di guerra - ma soprattutto dei campi di prigionia. Forse perché sono le esperienze più intense della vita. Forse perché sembrano le più intense (si rimpiange comunque tutto ciò che accade a vent'anni). E qui di giovani ce n'è parecchi.
Chiacchieriamo, è l'ultimo incontro, questo, anche se stiamo pensando di chiederne un altro. Mi viene in mente che ci devono essere delle parole ricorrenti, che risuonano spesso, o semplicemente termini che acquistano importanza, risonanze emotive. "Prepàrati" è un'imperativo che sentono spesso. E' l'agente che passa per avvisarti della messa, della scuola, dell'aria, del colloquio, della telefonata. Prepàrati. Cosa mai prepareranno? Quanti cambi d'abito avranno? E' una preparazione mentale, forse: prepararsi all'irruzione della vita, mica poco.
Massimino racconta di quello della cella di fronte che s'è impiccato tre volte e ogni volta urlavano e Massimino andava a sorreggerlo finché non slegavano il laccio di lenzuoli. La quarta gli è andata male (o bene, a seconda dei punti di vista). Male, pensano qui, perché aveva sempre scelto momenti in cui i soccorsi erano facili.
Discussione accademica:
Che gli fai a una che ti tradisce? Non a una che ti dice chiaramente che ti lascia, ma a una che ti promette di aspettare otto anni e poi la ritrovi con un altro? La ammazzi. Ma che sei scemo? Mi faccio altri vent'anni. E allora? La metto sulla strada. Lei sconta e io vengo risarcito. Ma è un reato anche quello. Due anni.
Quantificazione della pena. Tutto è quantificabile. Noi quantifichiamo in denaro, loro in tempo. Ma il tempo è denaro, no? Differenza solo apparente.
Mi informo sui loro colloqui. Ci si lamenta dei vetri in parlatorio (la pescheria): sono stati aboliti ma si c'è tempo fino al 2004. Intanto quelli che si erano scollati, invece di levarli li hanno riparati. Immagino che un colloquio possa essere spesso deludente: troppe aspettative, la mancanza delle parole giuste, il rituale della sit-com barese Catene (lodata da Aldo Grasso) con le inevitabili domande a fare da risposte: e che vuoi che faccia? e come vuoi che stia? e come dovevo venire? Fernando, infatti, per quanto felice sia per il colloquio, qualsiasi colloquio, è infastidito dal vizio dei parenti: portargli in carcere i guai di fuori. Chissà, magari è un tortuoso modo di consolarlo: si sta meglio dentro, abbiamo più guai noi di te. Massimino pensa che sì, il colloquio è colloquio (la presenza, la voce, gli odori) ma una lettera può comunicare di più anche se spesso anche la corrispondenza lo delude: trova banali le cose che gli arrivano, dopo due o tre mesi smette di corrispondere con le ragazze fuori.
Scopriamo che Michele ha mentito, il primo giorno, sull'entità della pena.
Sconclusioni
All'inizio degli incontri Michele ci aveva chiesto: ma che cosa otterremo da questo corso? Si era beccato risposte evasive ma non insincere. Non abbiamo attestati da distribuire, né conoscevamo la fine del percorso. Adesso, però, dovremmo poter tirare le somme. Si può certamente dire che noi abbiamo imparato qualcosa, che loro, anche se non dovessero esserci altri sviluppi, hanno occupato il loro tempo in maniera diversa.
Quando sono a scuola e vedo i professori, mi sento bene, tranquillo e a mio agio, perché parlando con loro, che sono delle persone squisitissime, mi dimentico di essere in questo luogo di segregazione. Questo perché è un dialogo vero e forse anche confidenziale, cosa questa che non accade con le altre persone che lavorano all'interno della struttura. Discutiamo della didattica ma anche di tante altre cose che succedono sia a me che a loro. Praticamente ho la sensazione di non trovarmi in questo luogo, come ho detto prima, così la mia mente, per una buona mezza giornata, può sentirsi libera veramente.
Fernando
Noi non siamo professori e io non mi sento squisitissimo ma il contatto con "altra gente" dovrebbe costituire per chi sta al chiuso almeno un sollievo, un diversivo. Un po' poco per un progetto rieducativo. Mettiamola così: tutto quello che possiamo fare, realmente, è rappresentare, impersonare, altri stili di vita. Noi siamo uno spot. Non rappresentiamo un mondo accattivante, com'è consuetudine nella pubblicità, ma un mondo diverso. Forse l'unica cosa veramente utile per i nostri amici è avere il più alto numero possibile di contatti con gente che fa cose diverse, magari strane, ma fuori dai soliti codici, fuori non solo dal carcere ma dal rione, dal bar, dalla famiglia stessa. E anche dal mondo dei "carcerieri", che sono sempre all'interno di logiche a loro ben note.
Mi rendo conto, che con tutta questa storia del rieducare - o educare? - e il far fare i compitini, e la metafora del collegio e il voto in condotta, il liceo artistico (Michele, che già lo frequenta da qualche mese, era convinto fino a oggi di frequentare il classico) e i corsi di giardinaggio (con i docenti del quale abbiamo avuto il piacere di condividere una lunga anticamera), comincio a pensare ai detenuti come a bambini, bambini duri e furbi (ma non lo sono tutti i bambini?). E, a proposito di bambini, mi ronza in testa un titolo che è diventato uno slogan: i bambini ci guardano. I detenuti ci guardano, potrebbe essere il titolo del tour. Lo zoo siamo noi. Il loro sguardo è addestrato, anche se gli occhi - predice Sofri - finiranno irrimediabilmente danneggiati dal bianco e dal neon. Valutano, soppesano, sgamano contraddizioni e superficialità. Ci giudicano.
Post scriptum. Scrivere in carcere
La prigione come musa: chi entra in carcere pare si senta in dovere di scrivere un libro. Romanzi, magari, come è capitato a detenuti americani divenuti famosissimi, o molto semplicemente, come accadde a Marco Polo, le avventure dei tempi andati, dei giorni "fuori". De Sade scrisse testi che qualcuno ama definire "filosofici". Di solito però si tratta di diari dal carcere. Non si sfugge all'archetipo: ognuno ha da dar conto delle "sue" prigioni. Non è solo un modo di occupare il tempo: anche perché, a volte, questi resoconti sono, almeno in parte, redatti posteriormente.
Occupandomi per un quotidiano del libro di un carcerato celebre, Giovanni Antonino, ex sindaco di Brindisi, mi sono trovato di fronte a osservazioni acute e soprattutto fuori consuetudine. Ho quindi scartato la possibilità che il libro, come molti instant-book di personaggi famosi, fosse stato steso da un ghost-writer: solo chi ha fatto esperienza del carcere può enucleare certi dettagli, effettuare collegamenti apparentemente balzani, creare immagini vivide e dirette senza la puzza dello sforzo, della ricerca retorica. Incongruamente, ma realisticamente, infatti, nelle situazioni più cupe ci si sofferma su ogni frivolezza: "Noto che la marca è Camay. Pensavo fosse scomparsa dai tempi di Carosello". "Slip con delle barchette disegnate che ricordano una vecchia linea di Naj Oleari".
Antonino galleggia sulle sue disavventure con l'autogonfiabile dell'ironia. C'è un distacco evidente tra gli avvenimenti e lo sguardo di chi racconta, tanto che l'autore stesso se ne a meraviglia: "Non riesco a capire se continuo a fare uno sterile esercizio di humour o sono i primi sintomi di un'incipiente dissociazione mentale. Mi dico che è giunto il momento di smettere di giocare, la corsa è finita, il treno è giunto al capolinea".
Il fatto è che dentro il gabbio ti prende la necessità di riconsiderare - rivalutare - ogni cosa. Sei dannato a ripensare la vita, a ricollocare te stesso, a normalizzare un'anormalità mostruosa. Il valore dei testi prodotti tra le sbarre sta in questa circostanza: in una situazione così estrema, così lontana dagli orizzonti delle persone comuni (gli scritti sono prodotti prevalentemente da persone non malavitose), lo choc e l'incredulità portano a guardarsi da fuori. E si dà il caso che questo guardare "da fuori", come un Adamo nell'Eden, o un marziano a Roma, sia precisamente la dote degli scrittori.